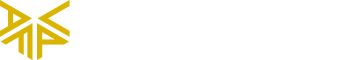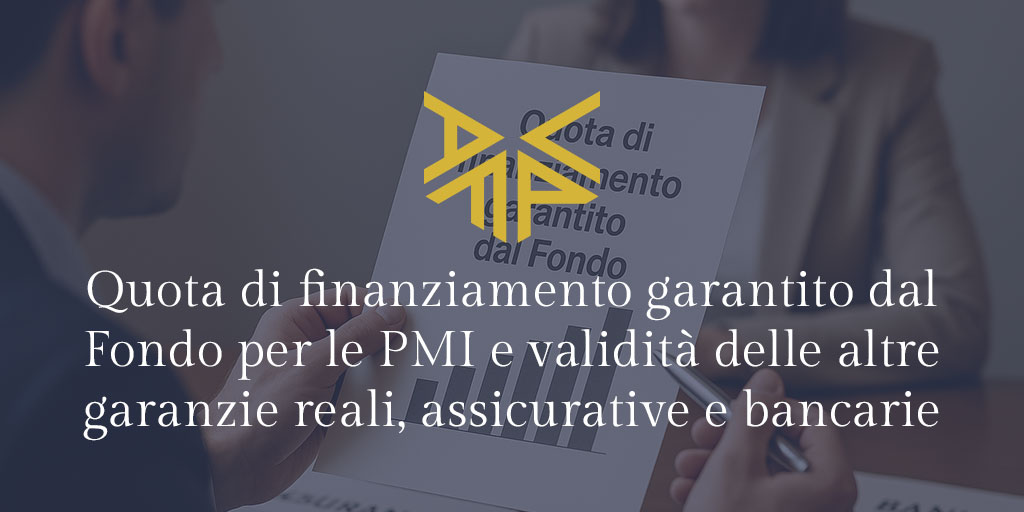Premessa: la nullità come strumento di controllo del contenuto negoziale
La pronuncia del Tribunale di Padova n. 805/2025, resa in una controversia in materia di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., solleva un tema di rilevanza generale per il diritto civile: quello della nullità contrattuale in relazione alla violazione di fonti secondarie dell’ordinamento. In particolare, la questione attiene alla validità di una fideiussione prestata da persone fisiche a favore di una società beneficiaria di un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica del Fondo per le PMI, laddove gli opponenti hanno eccepito la nullità della garanzia personale per violazione dell’art. 4, comma 4, dell’Allegato 1 al D.M. 23 settembre 2015, che vieta l’acquisizione di ulteriori garanzie su quote di finanziamento già coperte da garanzia pubblica. Il Giudice rigetta tale eccezione con una motivazione densa di implicazioni sistematiche, ribadendo il principio di legalità negoziale e l’inidoneità delle fonti sub primarie a generare effetti invalidanti nel diritto civile.
Il contesto normativo: divieto di cumulo e natura della garanzia prestata
La disposizione richiamata dagli opponenti (art. 4, comma 4, dell’Allegato 1 al D.M. 23/09/2015) stabilisce che “sulla quota di finanziamento garantito dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”. La finalità del divieto, come ben evidenziato dalla sentenza, è quella di “evitare di addossare ulteriori gravami e costi alle Imprese che si avvantaggiano della garanzia del Fondo”, impedendo loro di dover prestare garanzie aggiuntive onerose per accedere all’agevolazione. Il Tribunale evidenzia con chiarezza come “tale circostanza evidentemente non si verifica nel momento in cui il garante è una persona fisica a prescindere dalla contemporanea qualifica di socio o di amministratore” (punto 52), circoscrivendo correttamente l’ambito oggettivo di applicazione del divieto. Nel caso concreto, la garanzia contestata non è stata prestata dalla società finanziata, bensì da soggetti terzi in quanto persone fisiche, i quali non hanno assunto obbligazioni a carico dell’impresa non violando, quindi, il divieto di cumulo.
Il nodo sistematico: il rango della fonte e la nullità civilistica
La parte più significativa della pronuncia si trova al punto 54 della sentenza, dove il Tribunale affronta direttamente il tema della relazione tra fonte normativa e sanzione civilistica della nullità. La conclusione è netta: “la disciplina sopra citata (…) è contenuta in fonte del diritto secondaria, costituita da un decreto ministeriale: come tale, essa è inidonea ad incidere sulle regole di validità dei contratti, che vanno necessariamente rintracciate in una fonte normativa di rango primario”. Questo passaggio richiama implicitamente il principio secondo cui la nullità ex art. 1418 c.c. richiede la violazione di una norma imperativa dotata di sufficiente grado gerarchico, tale da incidere effettivamente sul contenuto del contratto. È un principio ormai consolidato in giurisprudenza, ma troppo spesso oggetto di forzature in chiave “funzionalistica”, tese ad attribuire efficacia invalidante a norme di dettaglio, anche se meramente regolamentari o amministrative.
Il Giudice padovano respinge tale approccio, richiamandosi a una visione rigorosa del sistema delle fonti, e osserva che la norma secondaria in oggetto “non risulta idonea ad intervenire sul rapporto di natura privatistica che si instaura tra l’istituto di credito e il fideiussore”, in quanto “finalizzata a dare regole in relazione alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di Garanzia”. In altri termini, si afferma che le finalità di policy pubblica, sottese alla disciplina secondaria, non si riflettono automaticamente sul piano civilistico.
L’efficacia “interna” delle norme regolamentari: strumenti diversi dalla nullità
Il Tribunale colloca la portata della norma regolamentare ai rapporti tra l’intermediario finanziario e l’amministrazione pubblica. La violazione del divieto può semmai legittimare un diniego di ammissibilità della garanzia pubblica, una revoca dell’agevolazione in autotutela (strumento introdotto con la legge n. 241/90) oppure un’eventuale responsabilità dell’istituto erogante nei confronti del Fondo.
Ma “non determina la nullità della garanzia personale prestata da soggetti terzi”, poiché “non si tratta di una norma che incide sul contenuto del contratto tra fideiussore e creditore” (punti 54-55).
Il Tribunale sembra dunque adottare una teoria della nullità come sanzione tipica e formalizzata, coerente con la struttura dell’art. 1418 c.c.
Conclusioni: conferma del principio di legalità nella disciplina dei contratti
La decisione del Tribunale di Padova offre una significativa riaffermazione della centralità del principio di legalità contrattuale, tanto nella sua dimensione formale quanto nella sua dimensione sostanziale. Essa chiarisce, in particolare, che le disposizioni regolamentari, anche se poste a tutela di interessi pubblici e aventi carattere vincolante, non possono determinare la nullità di contratti tra privati in assenza di una previsione espressa della legge. La nullità rimane dunque uno strumento eccezionale, tipico e sistematicamente chiuso, non suscettibile di estensione analogica o interpretativa.
Tale impostazione contribuisce a preservare l’equilibrio tra libertà contrattuale e controllo pubblico, evitando che finalità amministrative si traducano in una ingiustificata compressione dell’autonomia negoziale, e rafforzando la certezza del diritto nella materia delle garanzie personali.
Pertanto, le altre garanzie reali, assicurative e bancarie prestate da soggetti terzi restano valide.
Dr. Martina Dal Brolo Avv. Tommaso Fantuz