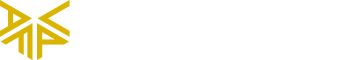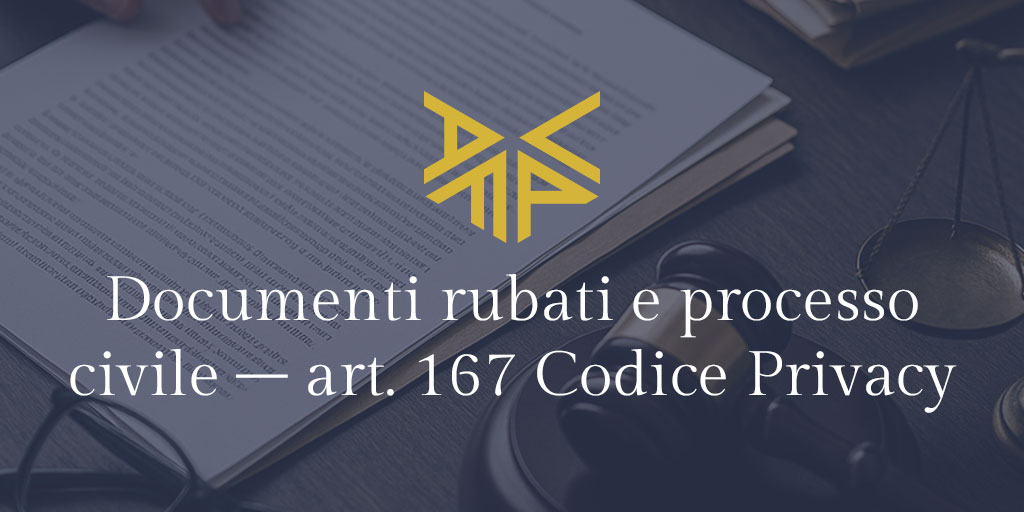La produzione di documenti nel giudizio civile è un fatto storico processuale, che non può essere impedito se non da preclusioni istruttorie o per espressa disposizione di legge.
L’introduzione dell’art. 167 D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, ad opera del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), ha posto nuove e rilevanti problematiche in materia di trattamento illecito di dati personali in ambito giudiziario. Il presente contributo analizza l’applicabilità di tale norma penale nei casi di produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali o sensibili, alla luce del bilanciamento tra diritto alla prova e tutela della privacy.
Solo incidentalmente si ricorda che, per i segreti commerciali (art. 98 del codice della proprietà intellettuale), opera una disposizione speciale (art. 121-ter c.p.i.) che attribuisce al giudice il potere di vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio, l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati.
Ben più delicata appare la questione posta dall’art. 167 cit., che punisce penalmente il trattamento illecito di dati personali (e non di segreti commerciali) effettuato da soggetti che, pur essendo tenuti a garantire particolari cautele (tra cui: avvocati, consulenti, amministratori pubblici), violano le norme poste a tutela dei dati personali, al fine di (dolo specifico) trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, ed altresì arrecano (elemento oggettivo ulteriore) nocumento all’interessato.
La norma si applica ai casi più gravi di trattamento illecito, specie quelli che coinvolgono dati particolari (ex art. 9 GDPR) o giudiziari (ex art. 10 GDPR), laddove la diffusione o la comunicazione avvenga senza un’adeguata base giuridica.
Nell’ambito del processo civile, è frequente che le parti producano in giudizio documenti contenenti dati personali altrui, talvolta sensibili (es. certificati medici, buste paga, corrispondenza privata, cartelle cliniche), di cui taluni già nella loro disponibilità ed altri, invece, acquisiti senza il consenso dell’interessato. Ci si chiede se, e in quali casi, tale produzione possa integrare un illecito penalmente rilevante ai sensi dell’art. 167 cit.
Da un lato, la legge processuale (specialmente l’art. 210 ss. c.p.c.) riconosce alle parti – sussistendo i presupposti di indisponibilità e di indispensabilità della prova acquisenda) – il diritto di ottenere l’esibizione o la comunicazione di documenti rilevanti ai fini della decisione, anche se contenenti dati personali dell’avversario o di terzi. Dall’altro lato, la normativa sulla privacy impone che ogni trattamento (ivi compresa la comunicazione in giudizio) sia sorretto da un’idonea base giuridica, rispettando i principi di continenza e pertinenza, con i necessari corollari e declinazioni in termini di proporzionalità e necessità.
L’art. 167 Codice Privacy impone una maggiore attenzione nella gestione dei dati personali in sede processuale. Avvocati, consulenti e parti devono valutare attentamente: la stretta necessità della produzione; l’adeguatezza delle misure di tutela (oscuramento, anonimizzazione, modalità di deposito); l’assenza di finalità lesive nei confronti del titolare dei dati.
E ciò, a maggior ragione, considerando che nel processo civile ordinario il giudice è sprovvisto dello specifico potere accordatogli dall’art 127-ter del codice della proprietà intellettuale, potendo al più – su istanza supportata da motivi legittimi della parte interessata ovvero, anche d’ufficio, qualora a tutela dei diritti o della dignità degli interessati – disporre, ai sensi dell’art. 52 del Codice Privacy, che sull’originale della sentenza o del provvedimento sia apposta l’annotazione impediente l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.
La giurisprudenza e il Garante per la protezione dei dati personali hanno chiarito che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali (senza specifica indicazione / limitazione delle modalità di loro previa acquisizione) è ammessa, purché: sia necessaria per l’esercizio del diritto di difesa (art. 6, par. 1, lett. f GDPR); riguardi dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo; sia effettuata nel rispetto delle regole processuali e con misure adeguate (es. oscuramento dati non rilevanti, deposito in busta chiusa, ecc.).
In assenza di queste cautele, ed in presenza di dolo specifico, l’autore della produzione potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente ex art. 167 cit.
Un recentissimo provvedimento dell’autorità penale del Tribunale di Vicenza (ordinanza GIP del 8 agosto 2025), confermando la tesi difensiva del soggetto datoriale, ha escluso l’applicabilità dell’art. 167 del Codice della Privacy, statuendo che l’aver prodotto in una causa civile (di lavoro) documentazione afferente la situazione contributiva e la documentazione contabile e le fatture relative a prestazioni del lavoratore con terzi non integra il reato de quo, in assenza di elementi fattuali oggettivamente indicativi di una effettiva lesione dell’interesse protetto, in quanto in quella sede la visione di detti documenti è stata riservata ai soli soggetti professionalmente coinvolti nella vicenda processuale, su cui gravava vieppiù un obbligo di riservatezza; e ciò a prescindere dalla circostanza che i dati personali prodotti in giudizio siano stati prodotti al di fuori dei limiti del corretto esercizio del diritto di difesa (così anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23808 del 29.3.2019).
L’art. 167 D.Lgs. 196/2003 costituisce illecito a dolo specifico in quanto il reo deve porre in essere il reato al fine di “trarre per sé o per altri profitto” ovvero con l’obiettivo di “arrecare un danno all’interessato”. Il profitto o il nocumento che dovrebbero integrare il dolo specifico neppure potrebbero astrattamente configurarsi in relazione ad una finalità di difesa (dell’indagato) a propria volta costituente diritto costituzionale di rango superiore a quello tutelato dalla citata norma. Quando invece la produzione risulti strumentale a ledere l’altrui reputazione, oppure sia esorbitante rispetto allo scopo processuale, può configurarsi l’elemento soggettivo richiesto dalla norma in parola, ossia il dolo specifico di “trarre profitto” o “recare danno”.
Neppure, per quanto qui interessa, potrebbe genericamente trovare spazio applicativo l’art. 167-ter Codice della Privacy, che prevede e punisce l’acquisizione con mezzi fraudolenti di un archivio automatizzato o di una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala. Il richiamo è d’obbligo, considerato che, per produrre in giudizio documenti che non siano “naturalmente” nella nostra disponibilità, è necessario che siano “finiti in qualche modo sul nostro tavolo”.
È nostra opinione che la fattispecie invocata non sussista – ex se e per la sola riscontrata produzione in atti giudiziari – sotto il profilo oggettivo, una volta rilevato che lo scarno materiale probatorio versato negli atti della causa civile: (a) non costituisce “un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso”, qualora i dati in contestazione (a1) non si caratterizzino per automatizzazione ed, inoltre, (a2) non rappresentino un “archivio” che, viceversa, (cfr. art. 4 par. 1 n.6 GDPR) è costituito da “qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati […]”; (b) non costituisce “dati personali oggetto di trattamento su larga scala”, salvo rinvenirsi “trattamento su larga scala” nella gestione di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato (in pratica non sussiste mai nel caso di trattamento di dati di una singola persona fisica).
Francesco Fontana Anita Crosara