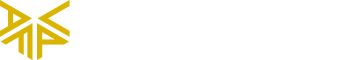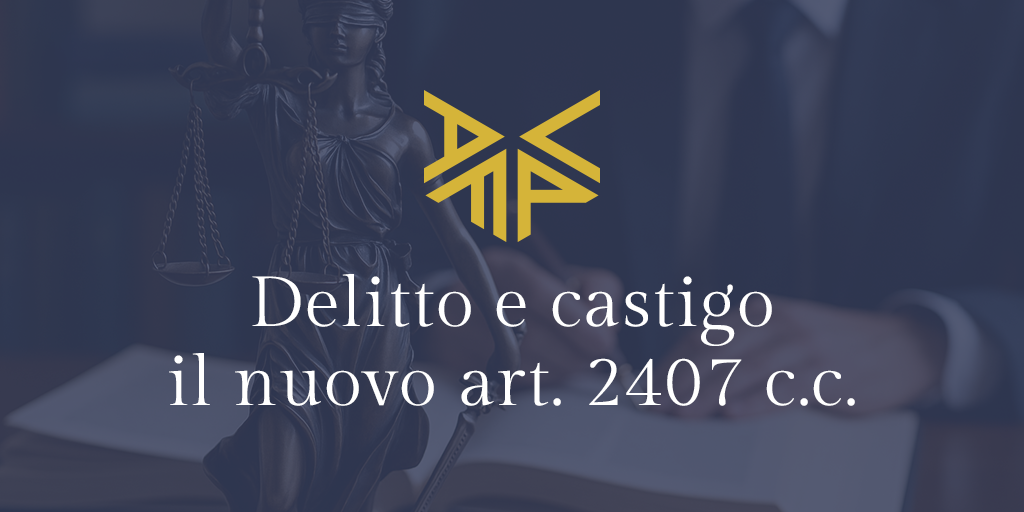L’art. 2407 c.c., novellato dalla L. 35/2025, introduce novità nella disciplina della responsabilità dei sindaci.
- Evoluzione storica e legislativa
La responsabilità dei sindaci nel codice del 1942 si fondava sull’assimilazione della loro funzione a quella del mandatario, con conseguente responsabilità solidale con gli amministratori per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri di vigilanza. Anche la riforma societaria del 2003 aveva sostanzialmente confermato tale impianto, precisandone la responsabilità solidale per “fatto proprio” connesso ai contegni degli amministratori, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
La versione ante novella del 2025 aveva innalzato lo standard di diligenza, richiedendo che i sindaci agissero con la professionalità adeguata alla natura dell’incarico, senza una previsione di massimale di responsabilità restava, in linea con la centralità della funzione di controllo e di tutela degli stakeholders.
La legge n. 35/2025, pur mantenendo la struttura generale della norma, introduce alcune novità rilevanti: la previsione di una limitazione preventiva di responsabilità massima (cap), graduata in base al compenso annuo percepito (e non meramente pattuito), superabile in caso di dolo (e non anche di colpa grave).
Inoltre, tra le innovazioni di maggior rilievo figura la nuova disciplina del termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci. Nel passato, decorreva dalla percezione del danno (con foriera incertezza applicativa e rischio di dilatazione potenzialmente indefinita della responsabilità dei sindaci), mentre ora è fissata in cinque anni dalla data di deposito della relazione di cui all’art. 2429 c.c. concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno (detta formulazione restando, tuttavia, perplessa circa la distinzione tra fatto originativo ed epifania del pregiudizio patrimoniale concreto).
Tale scelta legislativa introduce un parametro oggettivo, più facilmente verificabile, volto a prevenire l’insorgere di contenziosi a distanza di un arco temporale eccessivamente ampio.
L’obiettivo della modifica è quello di perseguire un bilanciamento: da un lato, ha individuato un periodo congruo per garantire l’accertamento di eventuali irregolarità; dall’altro, circoscrive l’esposizione dei sindaci, così da scongiurare il rischio di una responsabilità ultrattiva, suscettibile di incidere negativamente sulla futura operatività della funzione o sull’accessibilità delle coperture assicurative.
- La natura della norma e la sua qualificazione giuridica
La nuova formulazione dell’art. 2407 c.c. solleva dubbi sulla portata eccezionale o speciale della norma.
Può essere qualificata come disposizione eccezionale, di natura autonoma e derogatoria rispetto al sistema generale della responsabilità civile, oppure speciale e, pertanto, destinata a inserirsi in un quadro sistematico più ampio di continuità con i principi generali previsti dal codice civile.
La prima lettura trova fondamento nella forte cesura rispetto al passato, ossia nell’intento del legislatore di: (a) mantenere intatto il cap anche nell’ipotesi di colpa (grave o lieve che sia), nonché (b) introdurre un criterio rigido e predeterminato di decorrenza della prescrizione, ispirato a esigenze di certezza giuridica e di tutela dell’affidamento dei sindaci. In questa prospettiva, la disciplina rappresenterebbe una deviazione consapevole dal diritto comune, non suscettibile di applicazione analogica e impermeabile ai principi generali.
Di contro, la qualificazione della norma come speciale consentirebbe di mantenere un raccordo con i principi di cui al primo comma dell’art. 1229 c.c., in materia di colpa grave, preservando la coerenza sistematica dell’ordinamento ed evitando la creazione di micro-discipline frammentate. Si noti, incidentalmente, che l’art. 1229 c.c. si riferisce espressamente ai “patti” e non agli interventi legislativi, ma (nondimeno) appare cristallizzare un divieto sistemico di irresponsabilità soggettiva preventiva.
Alla luce di tali coordinate, la soluzione più equilibrata sembra quella di ricondurre la nuova disposizione nell’alveo delle norme speciali: l’art. 2407 c.c. introduce un regime ad hoc per i sindaci, ma non si pone come norma isolata o incompatibile con i principi generali della responsabilità civile.
In questa prospettiva, la novella del 2025 non sembra configurarsi come momento di frattura rispetto al diritto vivente, ma piuttosto come intervento di precisazione tecnica dotato di funzione integrativa. La natura speciale della norma risponde all’esigenza di certezza giuridica mediante l’introduzione di un criterio oggettivo e verificabile di decorrenza della prescrizione, senza però sacrificare i principi generali in materia di responsabilità civile e lascia un dubbio (concreto e di enorme portata applicativa) circa l’esclusione del cap nell’ipotesi (non menzionata dalla norma) di colpa grave.
- L’operatività del massimale
La previsione del massimale di cui alla riforma del 2025 si colloca in un solco di forte innovazione rispetto all’impostazione tradizionale, sollevando interrogativi circa la sua effettiva portata applicativa e la sua compatibilità con i principi di ordine pubblico (tra cui quello di cui al secondo comma dell’art. 1229 c.c.).
Il novellato art. 2407 c.c. stabilisce che, al di fuori dei casi di dolo, la responsabilità dei sindaci non possa eccedere determinati multipli del compenso percepito, senza comprendere la responsabilità per colpa grave. Ne consegue che anche condotte gravemente negligenti sembrerebbero attratte nell’ambito di operatività del cap, con un potenziale attenuazione della tutela offerta a soci, creditori e terzi. Una simile scelta legislativa appare problematica perché rischia di entrare in tensione con il principio di tutela dell’affidamento, che trova fondamento negli artt. 41 e 47 Cost., e con le esigenze di salvaguardia della trasparenza del mercato.
Nell’ambito civilistico si distingue tra ordine pubblico interno e ordine pubblico economico. Il primo si riferisce ai principi generali che garantiscono la stabilità dell’ordinamento. Il secondo, invece, riguarda la protezione degli interessi collettivi connessi alla correttezza dei traffici economici, alla trasparenza societaria e alla fiducia del pubblico risparmio.
Alla luce di questa distinzione, l’applicazione del cap previsto dall’art. 2407 c.c. sarebbe da interpretare in modo da non comprimere esigenze riconducibili all’ordine pubblico economico. Ciò significa che, anche in assenza di una esplicita previsione, appare giustificato escludere il limite risarcitorio nei casi in cui la condotta negligente dei sindaci incida su beni giuridici fondamentali per la trasparenza e la stabilità del mercato.
Una simile conclusione non solo tutela l’interesse della società e dei terzi, ma salvaguarda anche la coerenza logica e sistematica dell’ordinamento.
- Struttura del primo comma e ambito di applicazione del limite
Il primo comma dell’art. 2407 c.c. nella sua attuale formulazione individua due nuclei di obblighi: da un lato, il dovere generale di adempiere l’incarico con professionalità e diligenza; dall’altro, l’obbligo di garantire la verità delle attestazioni e di rispettare il segreto d’ufficio. La cornice principale di individuazione di questi doveri si rinviene nella previsione dell’art. 2403 c.c.
La questione sorge in quanto il secondo comma dell’articolo (applicazione del cap) sembrerebbe doversi applicare (solo) alla prima parte del primo comma dell’art. 2407 c.c.
Le violazioni della veridicità delle attestazioni o del segreto d’ufficio appaiono difficilmente compatibili con un meccanismo legale di limitazione della responsabilità. Esse, infatti, incidono direttamente sulla fiducia dei soci, dei creditori e del mercato, avvicinandosi per importanza a condotte dolose o di colpa grave, che l’art. 1229 c.c. considera comunque sottratte a qualsiasi limite di esonero o riduzione della responsabilità.
Il combinato disposto degli articoli 2403 e 2407 c.c. induce a circoscrivere l’ambito di applicazione del massimale ai doveri di vigilanza e diligenza propriamente intesi, escludendone invece l’operatività rispetto a quegli obblighi specifici su cui ruota il nucleo essenziale della funzione sindacale, ossia la garanzia di verità e la tutela della riservatezza, aventi una marcata funzione pubblicistica di protezione dell’ordine economico, che, come detto nel paragrafo precedente, escluderebbe una limitazione di responsabilità in capo ai sindaci.
- La nozione di “verità delle attestazioni”
Particolare attenzione merita il riferimento alla “verità delle attestazioni”, contenuto nell’art. 2407 c.c. e alla necessità di circoscrivere questa definizione in modo da chiarire l’ambito di responsabilità.
La verità attiene ai “fatti” e non alla loro valutazione (purché non dolosamente operata).
L’espressione deve intendersi riferita alla corrispondenza oggettiva dei dati e dei fatti certificati rispetto alla realtà effettiva (verità quantitativa), e non a valutazioni discrezionali o a giudizi di merito (verità qualitativa), i quali restano fisiologicamente esposti a margini di opinabilità. Si tratta, pertanto, di un dovere che attiene alla consistenza naturalistico-quantitativa dell’informazione societaria, il cui rispetto costituisce presupposto imprescindibile per la tutela dell’affidamento dei soci, dei creditori e, più in generale, del mercato. La funzione di garanzia qui attribuita ai sindaci non si esaurisce in un obbligo interno verso la società, ma si proietta all’esterno, incidendo direttamente sull’ordine pubblico economico in quanto volta a salvaguardare la veridicità dell’informazione societaria come bene di rilievo collettivo.
La violazione di tale obbligo, proprio per la sua gravità, espone i sindaci a una responsabilità particolarmente rigorosa, che difficilmente può essere attratta nel meccanismo di limitazione introdotto dal secondo comma dell’art. 2407 c.c. Ammettere che anche la falsità delle attestazioni possa beneficiare del cap significherebbe, infatti, legittimare una sostanziale deresponsabilizzazione anche di fronte condotte che compromettono la trasparenza del mercato e la fiducia del pubblico risparmio, valori di rango costituzionale (artt. 41 e 47 Cost.). In questa prospettiva, la responsabilità per la violazione dell’obbligo di verità dovrebbe essere interpretata come autonoma e non riducibile, in linea con i principi generali dell’ordinamento che assimilano la colpa grave al dolo (art. 1229 c.c.).
- Considerazioni conclusive
La riforma del 2025 segna un passaggio decisivo nella configurazione della responsabilità dei sindaci. L’introduzione del massimale, pur rispondendo all’esigenza di rendere l’ufficio più attrattivo e sostenibile, solleva dubbi sulla coerenza sistematica e sulla capacità di garantire un adeguato presidio di legalità.
La sfida interpretativa sarà ora affidata alla giurisprudenza chiamata a chiarire se il cap operi anche in caso di colpa grave; se debba essere escluso per violazioni di ordine pubblico (economico); se sia applicabile solo ad alcuni doveri dei sindaci e come debba coordinarsi con le norme sulle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza (art. 2399 c.c.).
Solo l’elaborazione giurisprudenziale potrà definire i confini effettivi della norma, bilanciando la protezione dei sindaci con la necessità di garantire l’affidabilità del controllo societario.
Noi una idea ce la siamo fatta. Delitto e castigo.
Martina Dal Brolo Francesco Fontana