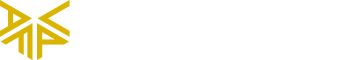- Premessa: la vicenda concreta.
Si è fatto un gran parlare, nelle ultime settimane, di delega di funzioni. Con la sentenza n. 25279 del 14 luglio 2025 (ud. 11 aprile 2025), infatti, la IV Sezione della Corte di cassazione ha affermato – fra gli altri – il seguente principio di diritto: “nell’ambito delle organizzazioni imprenditoriali complesse, non possono essere oggetto di delega, da parte dell’organo in posizione apicale, i compiti attinenti ai profili strutturali di organizzazione, tra i quali devono farsi rientrare quelli attinenti alla scelta delle modalità e della frequenza dei controlli sulla integrità e la sicurezza delle strutture e dei beni facenti parte del complesso aziendale. In ogni caso, anche in presenza di delega di funzioni, rimangono di competenza della figura apicale i poteri di sorveglianza e di eventuale intervento sostitutivo nei confronti del delegato”.
La reazione a caldo è stata da più parti quella di considerare la statuizione della Suprema Corte come l’inizio di un nuovo filone interpretativo più rigoroso e stringente sui limiti della delega di funzioni. In realtà, come si dirà a breve, si è trattato dell’ennesimo intervento con il quale il massimo Consesso ha ribadito principi già noti e consolidati: da una parte, che la delega di funzioni attiene a mansioni operative, non essendo la sua esistenza sufficiente a liberare l’organo apicale dall’assolvimento dei propri compiti di organizzazione e vigilanza; dall’altra, che si tratta di strumento essenziale per la corretta strutturazione dell’attività di impresa.
La suddetta sentenza è stata pronunciata nell’ambito del procedimento relativo alla c.d. strage del bus di Avellino del 2013 (incidente del viadotto Acqualonga), nella quale persero la vita 40 persone. In particolare, in quella tragica sera del 28 luglio 2013, lungo l’autostrada A16 nei pressi di Monteforte Irpino in provincia di Avellino, un pullman, a causa di un guasto all’impianto frenante e alla mancata resistenza del guardrail autostradale, precipitò da un viadotto, con le conseguenze anticipate.
Il procedimento penale sorto a seguito di tale drammatica vicenda ha visto sul banco degli imputati, fra gli altri, diversi dirigenti della motorizzazione civile di Napoli e di Autostrade per l’Italia.
In tale contesto, la Suprema Corte, dovendo affrontare il tema della responsabilità degli organi apicali di enti e organizzazioni complesse e ampiamente strutturate, ha avuto l’occasione di intervenire ed esprimersi anche in tema di delega di funzioni, nei termini di cui ora si dirà.
- La delega di funzioni: non un generico lasciapassare, ma un essenziale strumento operativo per garantire gli adeguati assetti organizzativi.
Di delega di funzioni si è discusso, anche in sede giurisprudenziale, per lungo tempo, ma un’espressa previsione normativa si è avuta solo con l’introduzione del D. Lgs. n. 81/2008, c.d. Testo Unico sulla Sicurezza sul luogo di lavoro, che all’art. 16, primo comma, prevede che “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto”.
L’obiettivo perseguito è evidente: nello svolgimento dell’attività di impresa – specie nelle organizzazioni complesse – non era più possibile ipotizzare un accentramento di funzioni organizzative e operativo-funzionali tutte in capo all’organo di vertice, anche solo per questioni meramente pragmatiche. E tuttavia, fatta l’Italia, bisognava fare gli italiani; rectius: codificato lo strumento, si poneva il tema del riparto di responsabilità da ciò derivante e della natura della posizione del soggetto delegato. Sul punto, il legislatore ha precluso dal principio ogni possibile discussione: dal tenore del terzo comma dell’art. 16, infatti, emerge l’intenzione di creare, tramite tale strumento, una posizione di garanzia “derivata”. Segnatamente: “La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.
Si tratta peraltro di impostazione coerente con quella costantemente adottata dal legislatore in tutti i settori di rilevanza della governance aziendale. Rimanendo nel perimetro del D. Lgs. n. 81/2008, si nota l’evidente dualismo nella ripartizione delle funzioni. All’art. 2, infatti, è individuato, quale vertice della struttura organizzativa dell’impresa, il datore di lavoro, in capo al quale permangono obblighi non delegabili di valutazione dei rischi e di vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni impartite, in quanto titolare di una posizione di garanzia “originaria”. Viceversa, all’art. 16 è disciplinata la delega di funzioni, che, come detto, configura in capo al soggetto delegato una mera posizione “derivata”, della quale sono propri compiti operativi e gestionali, ma mai di organizzazione generale dell’impresa.
Ampliando solo per un attimo il raggio della ricerca, si nota come la medesima impostazione sia rinvenibile anche nelle disposizioni del codice civile in materia di governance societaria. L’art. 2380 bis c.c. assegna in via esclusiva agli amministratori la gestione dell’impresa: tale disposizione va letta in combinato disposto con quella di cui all’art. 2086 c.c., che impone al datore di lavoro l’adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati [1], e con l’art. 2381, co. 3, c.c., che testualmente prevede che “il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega”. Ben si comprende anche in questo caso la permanenza in capo al soggetto delegante di un dovere di vigilanza circa l’osservanza delle prescrizioni impartite e il corretto esercizio dei poteri delegati, dovere al quale è peraltro connesso il potere di avocazione delle operazioni delegate. Si tratta di punto nevralgico e questione fondamentale, che ha costituito un profilo importante della riforma delle società: sui consiglieri deleganti permane quindi sempre un dovere di vigilanza, con il conseguente onere di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati (art. 2381, co. 3, c.c.), con il potere-dovere di chiedere informazioni a questi ultimi.
Ciò che ne deriva, in buona sostanza, è l’intenzione costante del legislatore (tradotta nella littera legis) configurare in capo al datore di lavoro (e, più in generale, in capo all’organo amministrativo) di un onere inderogabile e non delegabile di organizzare l’impresa e di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni adottate. Si tratta di posizione ormai granitica in giurisprudenza: “la delega di funzioni, invero, non determina il trasferimento della funzione datoriale nella sua accezione gestionale e di indirizzo né, di regola, la costituzione di una posizione verticistica in capo al delegato responsabile della violazione” (così Cass. pen., Sez. IV, 24 maggio 2022, n. 34943).
E, pur tuttavia, ciò non deve indurre a pensare, come pare sia successo a una prima lettura della recente pronuncia della S.C., che il principio di diritto ribadito sia di fatto un ridimensionamento dell’utilità pratica della delega di funzioni. Al contrario. Anche di recente, con la sentenza sul disastro di Pioltello, la Corte di cassazione ha ricordato quanto da tempo va affermando in merito alla responsabilità degli organi apicali nelle strutture complesse: “è noto che, sulla base di una consolidata giurisprudenza di legittimità, il ruolo del vertice di strutture complesse sia quello di assumere le ‘scelte gestionali di fondo’, sui cui radicare l’organizzazione societaria, di tal che l’attribuzione di una responsabilità, anche penale, in capo a questi soggetti deve sempre conseguire alla prova del fatto che le violazioni degli obblighi di sicurezza prescritti dalla legislazione a tutela dei lavoratori sia stata frutto di una inefficacia ab origine del modello di organizzazione dagli stessi validato”. L’attuazione pratica di tali scelte, però, non può prescindere da una delega delle funzioni operative a soggetti a ciò deputati.
In definitiva, la struttura disegnata dal legislatore e più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità è piuttosto chiara: l’organizzazione dell’impresa spetta imprescindibilmente all’organo amministrativo; in ambito prevenzionistico, è il datore di lavoro titolare dell’obbligo di valutazione dei rischi e di adozione delle opportune scelte gestionali, cui consegue l’altrettanto inderogabile e non delegabile obbligo di vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni impartite.
Ugualmente essenziale e imprescindibile è tuttavia la corretta ripartizione delle funzioni operative, che non possono essere accentrate in capo all’organo di vertice, pena l’inadeguatezza della struttura organizzativa. Dirimente è pertanto la strutturazione e l’individuazione di soggetti delegati titolari di compiti operativi, sulla scelta dei quali occorre altresì una doverosa verifica in punto di adeguatezza e competenza.
III. Conclusioni.
La portata applicativa e i corollari di quanto brevemente esposto sono davvero rilevanti.
Si pensi, solamente quale accenno, alla recente novella dell’art. 2086 c.c., con l’introduzione dell’obbligo per ogni impresa che operi in forma societaria o collettiva di avere un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
Ma si badi anche alle conseguenze in tema di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. L’assenza di una coerente, efficace ed efficiente strutturazione dell’impresa e, segnatamente in materia prevenzionistica, la mancata adozione di un articolato e valido sistema di deleghe, tale da rendere sostanzialmente effettiva (e non solo formalmente) la gestione del rischio, apre senza dubbio la strada alla configurabilità di quella “colpa di organizzazione” ormai requisito soggettivo necessario ai fini della contestazione della responsabilità 231.
Il caveat che si può trarre dalla recente pronuncia della Suprema Corte, in buona sostanza, è il seguente: il compito dell’organo di vertice dell’impresa è e rimane quello di compiere autonomamente le scelte gestionali e organizzative di fondo e di vigilare poi sull’osservanza delle prescrizioni impartite, la cui gestione e attuazione pratica è doverosamente delegata a soggetti a ciò deputati. In materia prevenzionistica, quindi, la figura del delegato di funzioni rimane centrale ed essenziale per l’adeguatezza della struttura aziendale, pur nella certezza che a esso vadano affidati compiti operativi e non di organizzazione generale.
[1] Cfr., più nel dettaglio, M. RIVERDITI, Da non confondere i piani tra delega di funzioni e obbligo organizzativo.